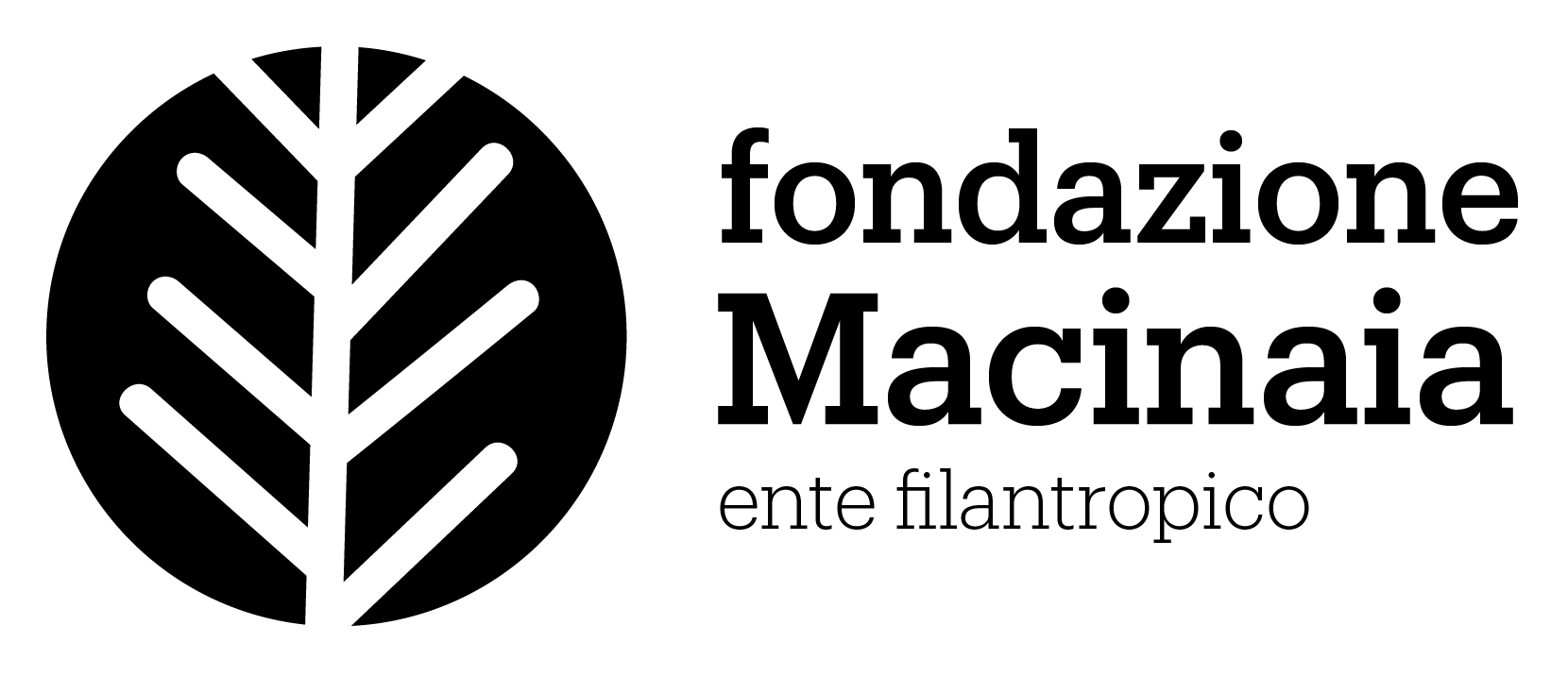Abbiamo bisogno di cattedrali
Siamo un crocevia di storie. Viviamo all’incrocio tra le storie che ci hanno raccontato (da dove veniamo, chi sono i nostri familiari, quali sono i miti fondativi del luogo che abitiamo) e le storie che raccontiamo riguardo a noi stessi. La diversità umana è in primo luogo una diversità di racconti, risiede, oltre che nella genetica, nel fatto che ognuno di noi conosce storie diverse e parla di sé in modo anche solo lievemente differente rispetto al proprio vicino. Ci sono storie che uniscono e storie che dividono: le prime formano le comunità, permettono loro di creare legami e connessioni, consentono agli individui di sentirsi meno soli. Le seconde individuano, fanno dire a chi le racconta “Questo sono io“, fanno sentire la propria differenza e dunque la propria unicità. Abbiamo bisogno anche di questo: di sapere che noi siamo noi e che la nostra vita, anche se forse non bella, è, come scrive Svevo nella “Coscienza di Zeno”, originale.
Porto con me le immagini della mia infanzia, dei passaggi essenziali della mia vita, di un giorno di luglio in cui decisi di iscrivermi alla scuola di specializzazione in Psichiatria per assecondare il desiderio, emerso in modo chiaro negli ultimi anni di università, di ascoltare e ricostruire le storie degli altri. Questo mi dà, almeno in parte, il mio senso di me stesso. Abito però anche altre storie, in cui il mio cammino individuale si mescola a quello di altri e mi permette di avvertire meno la solitudine del viaggio che ogni esistenza comporta: i racconti, ogni tanto rievocati con gli amici, del momento in cui ci siamo conosciuti, dei passaggi rilevanti fatti insieme, di una sera in cui ci siamo sentiti vicini, per le vie del centro o in una casa a San Frediano. Abito anche storie che non ho mai vissuto: le vicende dei miei genitori e dei miei nonni che costruiscono i modelli e i valori della mia famiglia e, allargando il campo, i momenti della Storia che hanno per me e per altri una qualche valenza e che dunque risuonano, in qualche modo, nel mio e nel nostro presente.
Pier Paolo Pasolini, in una sua poesia, si chiedeva: che madri avete avuto? Forse, oggi, dovremmo invece chiederci: che storie raccontiamo? Finita l’epoca delle grandi narrazioni, delle modalità interpretative del reale capaci di raggruppare un gran numero di persone sotto la stessa lettura delle dinamiche sociali, del proprio posto nel mondo e dei propri miti fondativi, finita l’epoca in cui ognuno aveva la propria comunità con cui ritrovarsi, simbolicamente, davanti al fuoco di una definizione valida per tutti, ogni individuo dà un senso originale a sé e al mondo ed è, dunque, un narratore originale. All’epoca della monodia, in cui ogni comunità aveva un canto o dei canti fondativi e li eseguiva a una voce sola, è seguita l’epoca della polifonia, in cui ognuno canta le proprie linee melodiche e dall’unione delle linee di tutti nascono consonanze e dissonanze. La polifonia fiamminga, che con le sue architetture armoniche sempre più complesse attraversò il Quattrocento e il Cinquecento, in fondo nasceva in un tempo, quello dell’Umanesimo e del Rinascimento, per certi versi simile al nostro, un tempo in cui la grande narrazione del cristianesimo medioevale era entrata in crisi e in cui l’uomo, con la sua unicità, tornava la misura di tutto. Forse Josquin Desprez ci è contemporaneo più di quanto crediamo.
E dunque la domanda sembra essere: come si accordano le storie? Come si trovano le consonanze e le dissonanze tra gli individui in un tempo in cui i canti non sono più uniformati dalle ideologie del Novecento, in un tempo in cui le relazioni sono rarefatte, in cui i luoghi di incontro sono sempre più difficili da costruire? Forse, è necessario in primo luogo essere consapevoli del proprio canto, delle proprie storie, in secondo luogo bisogna imparare ad ascoltare il canto e le storie degli altri in una società che, al contrario, porta a un investimento compulsivo su se stessi escludendo l’Altro se non come fonte di ammirazione o di aspettativa. Bisogna saper ascoltare per creare consonanze anziché dissonanze, ma anche questo non è sufficiente. I cantori che eseguivano la musica fiamminga si ritrovavano nelle cappelle delle cattedrali: vi erano dunque luoghi preposti all’incontro delle voci, in cui il cantare insieme aveva una funzione precisa come quella liturgica. Abbiamo bisogno di cattedrali, di luoghi preposti all’incontro e all’ascolto, di luoghi in cui vi sia il tempo di narrarsi e di ascoltare le narrazioni dell’Altro, di luoghi in cui tale reciproco raccontarsi abbia un significato e un obiettivo definito, affinché non sia vano lo sforzo di aprirsi con l’Altro e di lasciare all’Altro uno spazio dentro di sé. Abbiamo bisogno di luoghi in cui cantare: solo così le cetre di ciascuno non rimarranno appese ai salici di Babilonia mentre piangiamo l’esilio da una terra che possiamo chiamare casa e la diversità umana ci aiuterà a ritrovare vicinanze e a sentirci parte di una comunità.
Garbiele Santarelli (psichiatra)